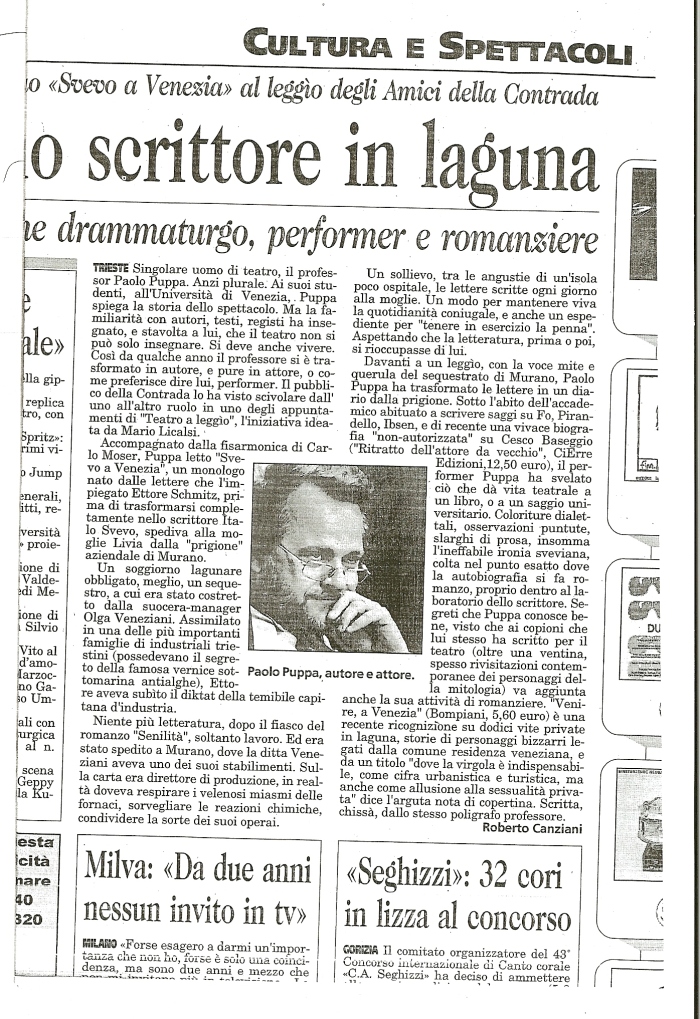FINALLY, FORMS DEFINE THEMSELVES
BY THEIR ABSENCE,
THEIR FELT OMISSIONS.
(Iahb Hassan, The dismemberment of Orpheus,
Oxford, Oxford University Press 1982 p. 10)
Sull’orlo del boccascena
Autore eclettico, capace di misurarsi con canoni, linguaggi e ruoli sempre nuovi, Paolo Puppa ha costruito nel tempo un corpus di opere che appare oggi uno dei più fecondi della drammaturgia contemporanea. Proprio le caratteristiche che rendono il suo nome uno dei più suggestivi della cultura letteraria e teatrale dell’Italia nel nuovo millennio, ne rendono difficile una presentazione lineare, una presentazione che da considerazioni iniziali approdi ad una qualsiasi conclusione definitiva. Si tenterà, allora, di mettere a fuoco delle questioni che attraversano i suoi testi in maniera tale da fornire un primo strumento di lettura utile tanto all’analisi della parte critica della sua opera quanto di quella più strettamente drammaturgica.
Mito, malattia, monologo e voci che si intrecciano, creano la tessitura di una drammaturgia eterodossa, spesso capace di valutare se stessa convergendo su considerazioni che fanno parte dell’opera critica. Vice versa accade spesso che la pagina critica sia costruita come racconto consumabile, piéce da palcoscenico capace di rapire l’attenzione del lettore fino ad identificarsi con una delle pagine della sua drammaturgia. Proprio qui, in questo strano intreccio di possibilità e di specificità tra arte drammatica e critica, risiede la novità dell’opera di Paolo Puppa. Sintesi perfetta di questa intelaiatura di trame e orditi, è la figura del Performer Monologante, figura in bilico tra il teatro narcisistico del mattatore e il bisogno di riscoprire una parola nuova, che esprima il senso di una dolorosa consapevolezza del presente.
Sull’orlo del boccascena, c’è un uomo, solo, che guarda i frammenti della sua esistenza sparsi intorno, tentare di ricomporsi in un’unità impossibile. E’ l’uomo postmoderno: esitante, indeterminato, instabile e dispersivo, costruttore di realtà parallele che possiedono uno statuto di verità altrettanto reale. Il postmoderno, se non altro per ragioni anagrafiche, è canone e ipotesi interpretativa da cui partire per tentare di dare uno statuto alla drammaturgia di Paolo Puppa, costruita sulla crisi d’identità dei personaggi, sull’impossibilità di una comunicazione costruttiva, su un tempo irrigidito ad asettico presente, su uno spazio che non riesce ad essere davvero collocato da nessuna parte anche quando i luoghi vengono descritti nei minimi particolari e su un modello letterario che non è distintamente teatrale e neanche esattamente narrativo.
Per fare ordine all’interno di quel corpus che fino ad ora abbiamo considerato come unicum concettuale, riflettendo su temi, novità e particolarità, è necessario riconoscere al suo interno delle fasi di produzione. In corrispondenza con l’arrivo del nuovo millennio, esattamente nel 2000, Puppa scrive Famiglie di Notte, edito a Palermo dalla Sellerio, e nel 2002 è la volta di Venire, a Venezia (Milano, Bompiani): due opere il cui confine tra teatralità e narratività si snoda lungo una invisibile linea di demarcazione per cui accade che il genere di appartenenza oscilli e non vi sia la possibilità di dare alle pagine statuto definitivo. Il 2003 è, poi, l’anno di Angeli ed Acque. Cinque commedie veneziane (Corbo e Fiore, Venezia). Un’opera nella quale confluiscono cinque testi drammaturgici descritti dall’autore stesso come “commedie”, cinque ipotesi, all’apparenza testi dialogici, ma effettivamente lunghi monologhi di personaggi che non riescono, o non possono, comunicare tra loro.
Anche il 2004 si configura come anno proficuo per il teatro di Paolo Puppa: escono infatti proprio in questo anno Si, Famose (in ‹Passaggi>, 2) e Parole di Giuda (inedito). Il primo è un testo nelle forme si rifà a Famiglie di Notte proponendo una serie di monologhi recitati da donne famose, donne dell’arte, della storia e della leggenda, legati tra loro dalla circostanza forse più contingente di questo inizio di millennio: il crollo del World Trade Center per mano del terrorismo. Parole di Giuda, invece, è un testo più impegnativo, perfettamente inscrivibile nel movimento postmoderno, caratterizzato dal ribaltamento progressivo della morale occidentale e forse anche dalla sua decostruzione. Il monologo testamentario del protagonista, Giuda, appunto, ribaltando le categorie di giustizia divina e predestinazione ne riscatta la figura facendolo apparire come l’unico, vero martire della cristianità.
Continua a leggere →