



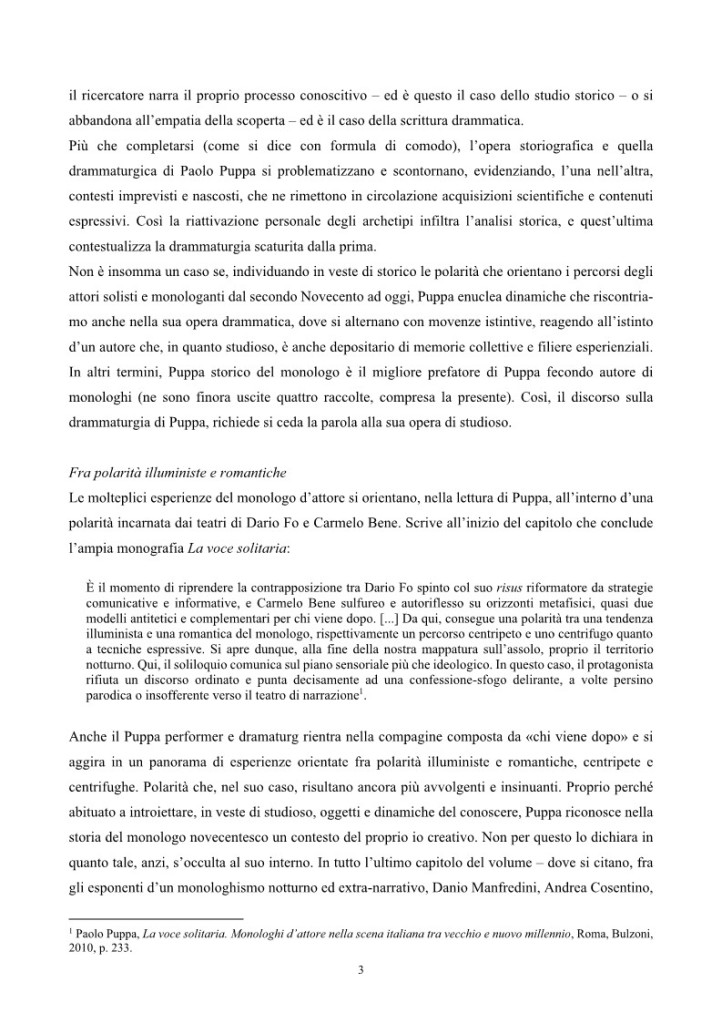




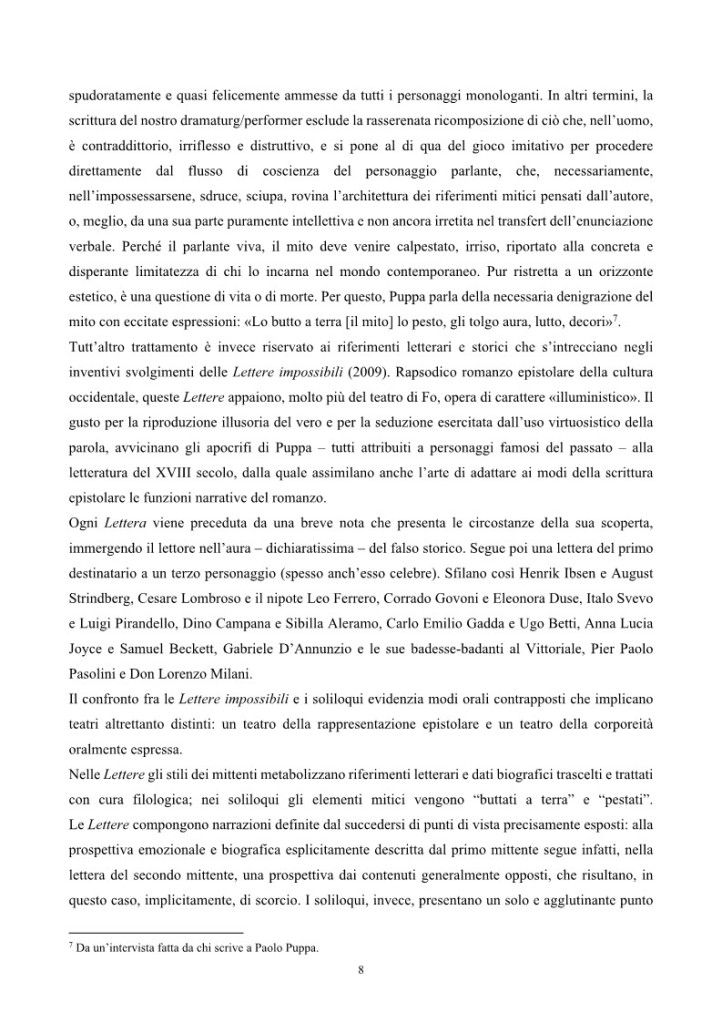
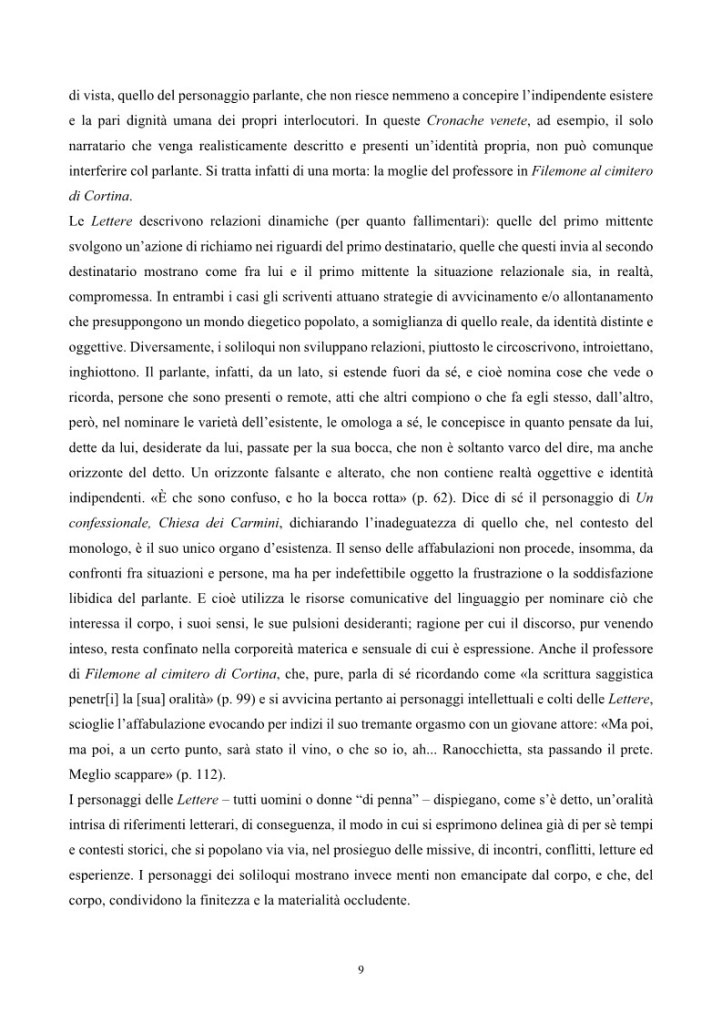

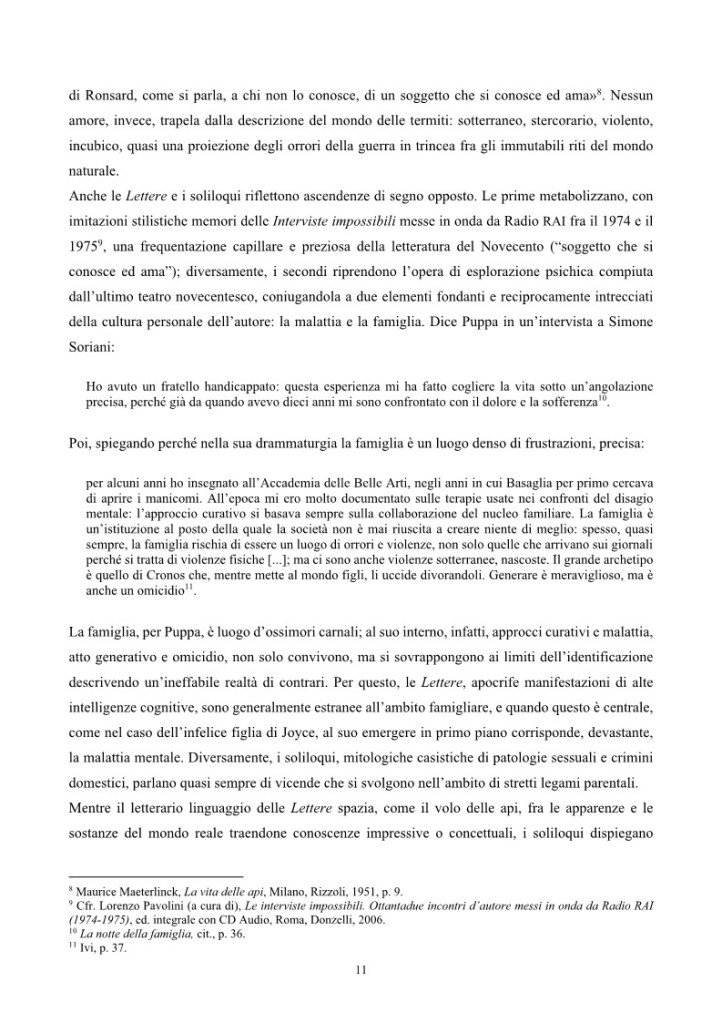



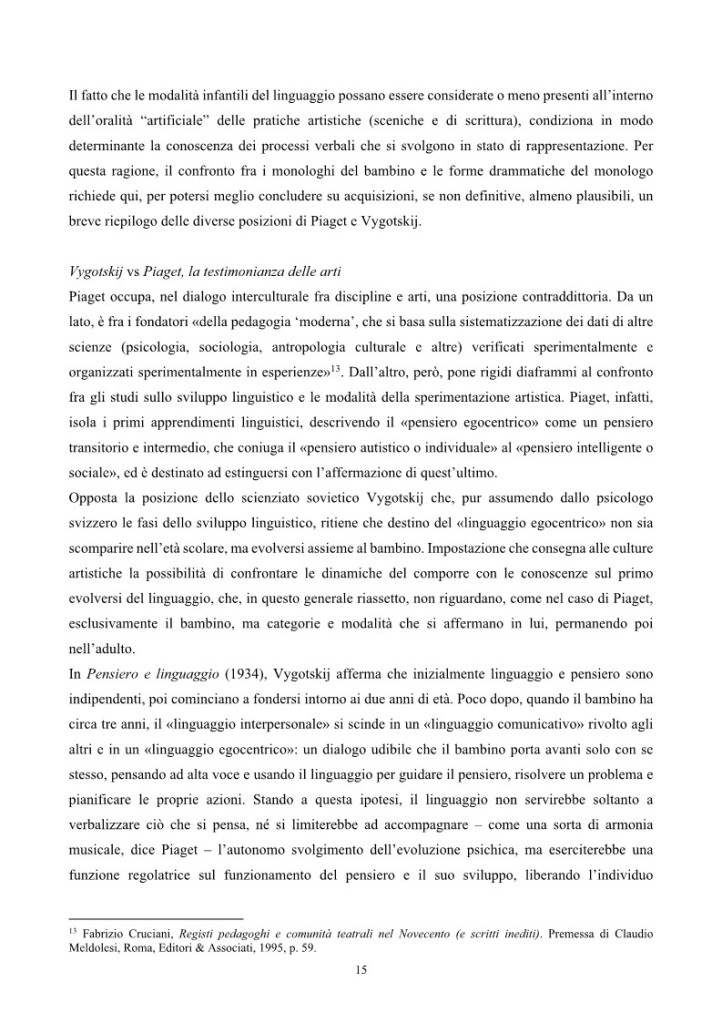
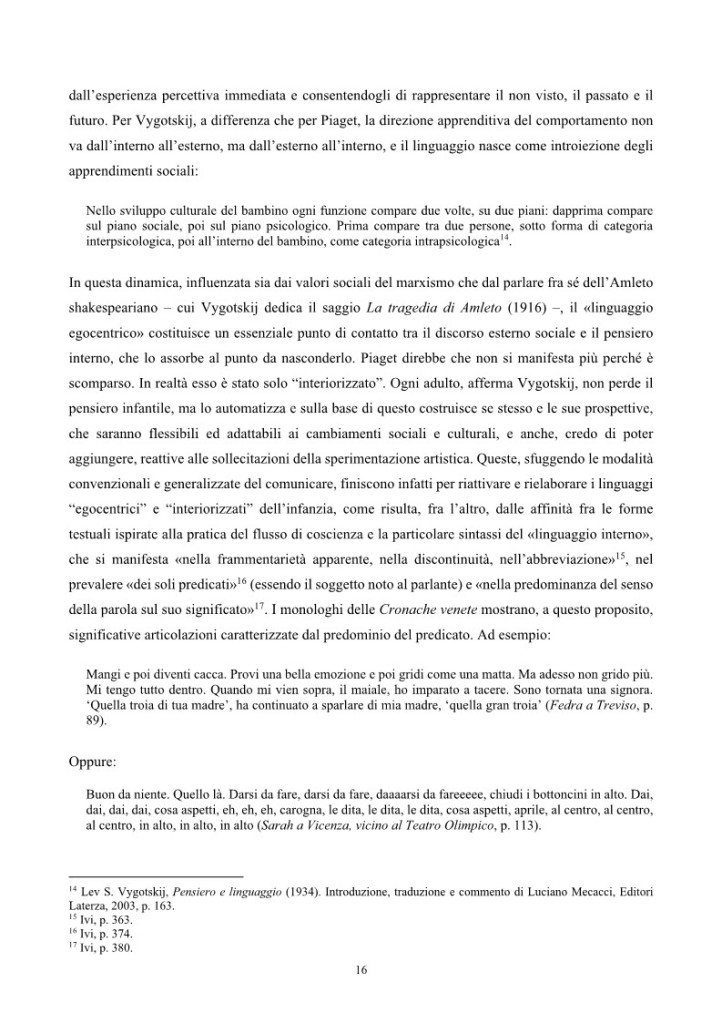


Occasionata dai vapori delle Terme euganee da lui scoperte di recente, mentre si rilassa tra piscine calde e saune scenografiche, la memoria si scioglie e Mario Isnenghi, il celebre professore di storia contemporanea in pensione, autorità internazionale e quasi star mediatica nel “grandeguerrismo”, torna indietro nel tempo e, con il recente Vite vissute e no. I luoghi della mia memoria (Il Mulino, 2020) ci racconta la sua vita. Ha sempre cercato di viaggiare, del resto, fin da ragazzo, in giro per il nostro paese, e oltre. Stavolta, sfoglia il calendario all’indietro. Ebbene, prendete Il paese dei Mezaràt (2002) di Dario Fo, epopea sulla prima infanzia dell’attore figlio di ferroviere attorno al lago Maggiore, e Il Regno (2014) di Emmanuel Carrère, scrittore francese che descrive la conquista del suo laico disincanto. Mescolate con garbo il tutto ed ecco queste madeleines. Quanto al primo aggancio, qualche perla dialettale alla Meneghello, il “giro del paleto” (dove passa la Regata sotto la sua casa in affitto sul Canal Grande di fronte alla Stazione) “pòpo,” “putelott” e i “piazzaròi” (partigiani comunisti) contrapposti ai “poaréti”, “faso tuto mi”, “Oeghel”, ossia Hegel tra i banchi di scuola. Per il secondo, il racconto procede come un romanzo di formazione, dal 1938, anno di nascita a Venezia, sino all’oggi, tra snodi e strappi, come dal mondo cattolico (mai democristiano e piuttosto inquieto tra Mounier, Bernanos, e Weil per quanto lo riguarda) dopo i diciott’anni e dalla FUCI, l’Associazione degli universitari, all’UGI, alla sinistra e/non comunista. In mezzo, il rodaggio tra il ’58 e il ‘59, all’ombra di «Questitalia» di Wladimiro Dorigo, suo mentore geniale battitore libero con il gusto del minoritario. Autofiction storica, questo il genere ibrido del volume. E l’autore del resto fa lo storico nel crinale della letteratura, doppia competenza che agli inizi non ne ha agevolato la carriera accademica. (Il resto dell’articolo è consultabile sulla testata Doppiozero)
Andrea Fallani (Università di Firenze)
Italian Studies in Southern Africa/Studi di Italianistica in Africa Australe (ISSA) 33.1/2020
Scene che non sono la mia di Paolo Puppa: motivi, temi e protagonisti del teatro contemporaneo
Lo sguardo che Paolo Puppa, in Scene che non sono la mia. Storia e storie di violenza nel teatro tra due millenni, getta sul teatro contemporaneo, ma che in verità si allarga ben oltre il secolo breve (fin dal primo saggio della raccolta, dove l’autore coglie la drammaticità biblica della scena di Abramo), è sicuramente uno sguardo comparatistico, che spesso travalica i canonici confini, spesso troppo rigidi, dei generi letterari, nonché delle arti. Come chiarisce lo stesso autore nella breve Introduzione, il titolo è una sorta di precisazione (data la «doppia professione» di Puppa, critico teatrale e «commediografo-performer»), una precisazione che diviene ancora più importante se si osservano le «angolazioni diverse» con cui vengono presentati i «tredici personaggi della mia biblioteca personale, letterati e attori con incroci di mansione»[1]: da Pirandello a Svevo, passando per Fo e Scabia, ognuno ci viene presentato come un personaggio di un unico dramma, che si muove su una scena che viene illustrata fin dai primi tre saggi, per l’appunto accopparti in una sezione dal titolo Fondali-sfondi. Da questo trittico inziale di studi generali emergono i fili conduttori dell’intera raccolta, come l’umorismo e l’ironia, le dinamiche dei rapporti familiari (osservati da una prospettiva psicoanalitica) e le loro rappresentazioni artistiche, o l’importanza della Bibbia e dell’ebraismo all’interno della cultura e dell’arte occidentale; vengono anche presentati, o anticipati, i protagonisti dei successivi saggi monografici, come Svevo o Pirandello.
Il primo di questi «tre studi generali» si concentra, con taglio ora drammaturgico, ora psicoanalitico o antropologico, sulle origini della civiltà occidentale e, in particolare, sulla «teatralità della Bibbia», il personaggio di Abramo e il suo rapporto con Dio, un rapporto che è soprattutto «quello di padre padrone e figlio schiavo»: un Dio-padre che, come in un Bildungsroman ante litteram, forma e costruisce la personalità del figlio, e quindi del popolo eletto, attraverso «continui sradicamenti dalla terra e dalla famiglia», al fine di educarlo «alla sottomissione e alla formazione del carattere», da cui si origina «il costante destino diasporico imposto alla creatura»[2]. Sebbene talvolta il figlio si permetta col Padre «confidenze e richieste umane», il rapporto tra Abramo e Dio è caratterizzato dall’ubbidienza e l’episodio del sacrificio di Isacco, tra i più citati nelle arti quanto dimenticato negli altri Libri della Bibbia, è emblematico di questa sottomissione; un episodio, quello del padre che sacrifica il figlio per ottemperare a una volontà divina e in ossequio a un bene superiore, che si può ritrovare anche nell’epica classica (Ifigenia) e che nel Nuovo Testamento, con il sacrificio di Cristo, giunge a «rimuovere la presenza obbligante del sacrificio stesso»[3]. Dunque una «pulsione all’infanticidio» e un affascinante «orizzonte luttuoso» che ritroviamo, rimodulato di volta in volta, in tutta la storia della letteratura occidentale, e che emerge con particolare evidenza in epoca moderna e contemporanea, soprattutto nell’«immaginario borghese alla fine del secondo millennio»: dal Romanticismo all’Espressionismo, da Pasolini a Joyce, per non parlare di Italo Svevo, con la sua incompleta Rigenerazione, dove è il nonno a manifestare la pulsione infanticida verso il nipotino. Se in tutta la letteratura ebraica moderna, da Svevo a Kafka, la risata convive con il pianto, e questo aspetto tragicomico e grottesco deriva anch’esso dalla Bibbia, dove è frequente l’«apologo gioioso» tanto che «l’ambivalenza tra simpatia e avversione, tra presa in giro e affettività» può portare a domandarsi se «per caso il Signore non giochi appunto con Abramo, allorché gli impone il sacrificio, con tutte le assicurazioni di una infinita progenie dategli in precedenza»[4]. Nasce così una distinzione, con l’aiuto teorico di Jankélévitch, tra umorismo ed ironia: «L’ironia è a volte sprezzante e aggressiva. L’umorismo, al contrario, non esiste senza la simpatia. Esso è il sorriso della ragione. Mentre l’ironia misantropa mantiene nel rapporto con gli uomini un atteggiamento polemico, l’umorismo com-patisce con la cosa derisa»[5]; è questa ironia, intesa come una «scuola rabbrividente e terapeutica di disincanto», ad emergere spesso nelle scene bibliche relative ad Abramo e nelle opere di scrittori moderni di origine ebraica come Svevo e Kafka.
Il saggio successivo sposta l’attenzione sulla più piccola struttura sociale umana («cellula che riproduce e ricicla l’organizzazione sociale al suo interno»), ossia la famiglia e come questa venga rappresentata, nel teatro dell’ultimo secolo a partire da Ibsen e Pirandello, nei suoi aspetti più oscuri e notturni. Esemplare è Affabulazione di Pier Paolo Pasolini, che, nella sua dimensione onirica e visionaria, «mette a fuoco uno dei capisaldi del sottosuolo novecentesco, cioè la famiglia di notte», dove «le parentele si sciolgono e cadono i tabù»: il plot dell’opera non si muove più intorno alla coppia «orizzontale» marito-moglie, bensì a quelle verticali «dove si sprigiona una maggiore energia desiderativa»[6]. Qualcosa di simile avviene in La novella del buon vecchio e della bella fanciulla di Svevo, dove il protagonista, «senex lascivo e corruttore», inchiodato al letto da un infarto per le troppe «copule compulsive» con la giovane sedotta, finisce per progettare un «manuale pedagogico su come i vecchi dovrebbero comportarsi con le giovinette, amandole come un padre dovrebbero comportarsi colle giovinette, per il fatto che ogni abbraccio tra i due esala aromi e miasmi di incesto»[7]. Con la frantumazione e l’umiliazione dello statuto dell’Io iniziata con il Novecento, anche la famiglia lascia trasparire le sue pulsioni più oscure e incestuose, «fantasticherie fascinose, miste di orrore e di bellezza» che vengono alla luce nelle ultime sperimentazioni sveviane, in Affabulazione di Pasolini, nei drammi di Ibsen e in tutta l’opera pirandelliana, dalle novelle al teatro, passando per l’epistolario con Marta Abba e fino alla «compiuta fusione nel romanzo sul cinema, basato sul trionfo dell’immagine nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore».
L’ultimo saggio della sezione prende le mosse dalla constatazione etologica, che a sua volta si rifà ad Aristotele, che una differenza tra gli uomini e gli animali risiede «nel fatto che le bestie piangono ma non ridono»: se il tragico tende a una dimensione «metastorica», il comico è «radicato» in un contesto ben preciso, e, per questo, se la tragicità è accettata dal potere, la comicità è invece spesso censurata. Fin dall’inizio del Novecento, secolo che offre molte occasioni per piangere e poche per ridere, si assiste, paradossalmente, a «sfiati fisiologici dalle tensioni e dal dolore», così che la comicità dilaga proprio di fronte alla tragedia e si nota «un’indubbia voglia di ridere sulle macere e sullo strazio dei defunti»: la risata beffarda delle avanguardie storiche mira «allo sbeffeggiamento, abbassando ciò che sta in alto»[8]. Con lo scoppiare della Grande Guerra, osservando la scena teatrale italiana, si nota la ricorrenza di «plot sincopati» dove «si afferma la polarità tra buon giovane e cattivo vecchio»; il protagonista è, spesso, uno studente insofferente «verso la disciplina imposta dall’alto della cattedra», un giovane futurista che «pare coltivare un autentico complesso del muscolo», tanto che il «suo completamento professionale sarà pertanto la figura del lottatore» o del «boxeur», colui che trasforma il salotto in ring. Dall’altra parte, l’antagonista senex per eccellenza è il «pacifista», di cui si intuisce «la latente capacità a sopravvivere, a riemergere dopo, ripristinando il vecchio mondo»[9]. Anche la lingua risente profondamente dell’atteggiamento aggressivo del futurista verso il senex, così che, tra «accensioni fono-sintattiche», «anafore ritmiche» e «iperbole dello stile nominale» si genera un «caos eracliteo in cui precipita frantumandosi la grammatica dell’Io»: è la «crisi della lingua» che, per un certo periodo, diviene «esplosione di significanti», venendo meno, soprattutto sul palcoscenico, il «principio di individuazione allocutorio». Persino in Pirandello, «regolatore e mediatore delle avanguardie» all’interno della tradizione, si possono ritrovare aspetti linguistici tipicamente futuristi: i repentini cambi di registro linguistico nell’Enrico IV, da «battute da moderna tabernaria» a impennate verso un «sermo ironicamente elatus, rispetto al rusticus, e al medio alto della lingua di Enrico IV, con lessemi di forte impronta toscaneggiante»[10]. La «spaccatura» che Pirandello porta sul palcoscenico è quella tra due sistemi, «uno logico raziocinante e uno pulsionale-notturno», da cui consegue «l’impotenza della parola a comunicare» a causa della «tragica autorefenza e la non corrispondenza tra significanti eguali e significati diversissimi per ogni allocutore»: è la «sfiducia nel potere comunicativo della parola» che costringe l’altro a rimanere «enigma invalicabile e indecifrabile», in un orizzonte nichilista e relativista, che viene sempre affrontato da Pirandello «in chiave umoristica, ossia in termini gioiosi e ludici, e insieme tragici, secondo la consueta, voluta incertezza di giudizio cara allo scrittore»[11].
Seguono poi sette saggi di taglio più monografico. I primi due sono incentrati su due autori classici del Novecento italiano, Pirandello e Svevo, ma entrambi sono presentati da una prospettiva originale: da una parte, il rapporto tra Pirandello e capocomici, attori e attrici, colto attraverso le pagine di epistolario, con particolare attenzione alla «furiosa sublimazione» di Marta Abba, alla sua trasformazione progressiva in «personaggio» di un Bildungsroman; dall’altra, un dialogo a distanza, un confronto tra Svevo e Kiš, da cui emergono sorprendenti analogie (come la «funzione difensiva dell’umorismo» in un orizzonte «materialistico, nichilistico al limite»), derivate, in parte, dalla cultura ebraica, percepita e vissuta diversamente, ma comune a entrambi («Ettore era tutto ebreo essendolo entrambi i genitori. […] Kiš, viceversa, non può dichiararsi tale, dal momento che la madre era montenegrina di religione ortodossa, mentre il padre, ispettore ferroviario ungherese, era ateo, non certo praticamente»), e anche dall’incontro, reale o letterario che sia, con Joyce. Il terzo saggio è incentrato sul ciclo narrativo di Nane Oca di Giuliano Scabia, autore e artista poliedrico che ben si presta allo sguardo comparatistico di Puppa. In una piccola comunità di lettori/spettatori alle porte della fantastica Pava (Padova) si ricrea un «milieu indispensabile», una «comunità separata» dal resto del mondo, dove «la gioia di narrare è pari a quella di ascoltare a bocca aperta». Uno dei tratti distintivi di questo ciclo è un certo «picarismo naif» che sottende a «una sospensione del giudizio verso il mondo», una «teodicea, secondo cui il male non esiste, e non sono concesse depressioni gnostiche o attese apocalittiche», così da venir meno ogni «manicheismo»[12]. L’autore di questo «assemblaggio di favole» non è unico e, al contrario, nel testo «esplode un’autorialità diffusa»: esiste l’«autore invisibile, colui che sovrintende al disegno generale del mondo», l’«io autoriale» che «entra ogni tanto in scena e si rende visibile, curioso del reale, testimone coinvolto» e che tuttavia «appartiene al Tempo». Diversi autori per ogni piano narrativo, con personaggi che «passano con disinvoltura da una cornice all’altra»; storie su storie che generano altre storie, in Nane Oca la morte viene sconfitta, o almeno allontanata, dal mythos: «L’antico mito di Schéhérazade rivive qui, nel senso che la catena di storie non solo allontana la fine ma allo stesso tempo invita i morti, li richiama dal passato, mentre il falò attorno cui ci si riunisce per l’ascolto assume la funzione di una seduta spiritica, in chiave popolaresca e bonaria, non tenebrosa»[13]. In un «orizzonte spinoziano» il sacro «si fa osceno e viceversa», mentre Dio è rappresentato spesso come «un guardone acustico» e gli aspetti più alti dell’esistenza convivono e hanno la stessa dignità dei più bassi; allo stesso modo, in questo universo letterario permeato da un «intenso panteismo», mondo umano, animale e vegetale sono separati e fusi come in un bestiario medievale. La fusione di elementi eterogenei in una sorprendente concordia discors, si rispecchia anche sul piano linguistico, dove è si riscontra una «babele euforica», in quanto «ogni personaggio ha la sua lingua» inventata su misura, e quindi la presenza di «impavidi neologismi»[14].
Segue un grande balzo all’indietro nel tempo con un saggio su Kleist, con in primo piano il copione dell’Anfitrione, dove «l’io, su cui tutto l’illuminismo ha costruito certezze e trionfi, viene privato della propria identità», così che nascono motivi presenti in tutta l’opera kleistiana e che diverranno grandi temi nel Novecento: la comunicazione tra personaggi è spesso «disturbata», l’altro è, in buona parte, un mistero e il reale viene frequentemente soggettivizzato da «personaggi esaltati» che «non potendo tener testa al principio di realtà» ne creano uno, in una «universale anamorfosi per cui ognuno altera l’identità dell’altro in quanto spinto dall’amore-illusione o dal malanimo»[15]. Nelle ultime tre monografie della sezione il taglio comparatistico diviene più evidente, in quanto i protagonisti di questi saggi sono soprattutto attori e attrici o performer, e solo secondariamente drammaturghi. Nel saggio su Maria Callas, il piano letterario della riflessione è costituito dal mito mediatico che ha sublimato la donna, rendendola divina, in consonanza con quanto era accaduto, qualche decennio prima, con Eleonora Duse; da cui un interessante confronto ravvicinato sulle diverse performance recitative delle due attrici:
Se insomma è la metamorfosi il motivo fondante dietro il lavoro di ogni interprete, la Duse si costituisce proprio in quanto natura per eccellenza proteica. Temperamento nervoso, quintessenza riconosciuta della donna moderna, Eleonora flette e torce la voce con esiti striduli o torsioni gutturali all’insegna di una disarmonia e di una sprezzatura inseguite quali cifre personali. Anche la Callas, ad esempio nei panni di Lady Macbeth, fa uscire dalla sua gola un suono aspro […]. E nondimeno la Lady Macbeth di Maria riesce fascinosa, nell’etimo ambivalente del termine, in quanto sprigiona una malìa non resistibile, nel medesimo modo con cui la Duse riscattava le sue adultere e le sue peccatrici, trasformandole in vittime di se stesse oltre che della crudeltà oggettiva delle norme sociali.[16]
Dal Risorgimento italiano arriva la prosa «rapida e impulsiva» di Gustavo Modena, carbonaro e mazziniano, un «passionale» in grado «di far convivere in sé dosi indubbie di idealismo romantico con un illuminismo materialista di fondo», attore, traduttore e adattatore formidabile di drammi francesi, autore, tra l’altro, dei Dialoghi. Una drammaturgia «sospesa a metà tra il manifesto e il sogno» che ha in Dante un «modello stilistico e ideologico», un modello a cui cerca di far aderire anche la propria vita: «Leggenda in vita, che attira a teatro, dove spesso si va a vedere l’esule, l’attore che nel 1831 a Bologna e a Venezia nel 1848 abbandona il palcoscenico per imbracciare il fucile»; nel suo eclettico e straordinario curriculum non potevano quindi mancare la dantate «ovvero singolari letture del poema dantesco» dove l’attore «sembra davvero avere incorporato in sé il poeta della Divina commedia». L’ultimo protagonista della sezione è Dario Fo, un artista che si presta particolarmente bene a un approccio comparatistico, in quanto le sue opere, come Mistero buffo, sono difficilmente inseribili all’interno delle categorie tradizionali; lo stesso dicasi per i suoi “figli”, ossia tutti quegli artisti delle generazioni successive, la «numerosa schiera di narratori monologanti», da Paolini a Moni Ovadia, che instaurano molti parallelismi e filiazioni con il teatro di Fo. Uno degli aspetti e motivi più caratteristici di questo teatro è una «forte contrapposizione fra la Chiesa alta, corrotta, venduta al potere e quella che sta dalla parte dei paria, degli ultimi, fin dall’epoca medievale»; se si mettono a confronto Il paese dei Mezaràt di Fo e Album di Paolini, si nota un’ulteriore analogia nella «struttura del romanzo di formazione presente quale montaggio discorsivo in ambedue i cicli narrativi»[17]. Ci sono anche però alcune differenze: da una parte la recitazione di Fo è unica, in quanto ricopre un ruolo importante la mimica, denotando una «istanza iconica» che «palpita bel sottofondo professionale», dall’altra, la Storia è centrale nelle opere di Paolini e degli altri narratori monologanti, mentre Fo la rovescia in una «controstoria grottesca».
Nell’ultima sezione, Varie ed eventuali, sono contenute tre brevi riflessioni su autori prettamente contemporanei, come Fernando Marchiori con la sua riflessione drammaturgica sul rapporto uomo-animale, o Loretta Innocenti che, in un suo saggio, ha indagato diacronicamente gli adattamenti neoclassici di Shakespeare dalla Restaurazione inglese alla metà del Settecento, oppure Eugenio Barba, un «regista» che «non crede alla drammaturgia scritta» ma, come un sciamano, nei suoi libri, «comunica con i grandi maestri del passato, dunque con i morti». Così dalla scena di Abramo alle sperimentazioni teatrali più recenti, in Scene che non sono la mia lo sguardo di Paolo Puppa si rivela particolarmente attento ai dettagli, agli aspetti apparentemente marginali di ogni autore o scena, teatrale o meno, riuscendo a superare agilmente i confini tra generi e arti diverse; una raccolta di saggi che possiede una forte coerenza e coesione strutturale, non tanto per l’argomento trattato, che anzi spesso esula dal teatro vero e proprio, ma quanto piuttosto per la duttilità dell’approccio critico e la ricorrenza di motivi, come l’ebraicità o l’umorismo, che, sottilmente, legano tra loro i tredici protagonisti del libro.
[1] Paolo Puppa, Scene che non sono la mia. Storia e storie di violenza nel teatro tra due millenni, Pisa, Titivillus Mostre Editoria, 2019, pp. 7-8.
[2] Ivi, p. 13-14.
[3] Ivi, p. 18-19.
[4] Ivi, p. 23.
[5] Ivi, p. 24.
[6] Ivi, pp. 32-33.
[7] Ivi, p. 34.
[8] Ivi, pp. 43-44.
[9] Ivi, pp. 47-48.
[10] Ivi, pp. 48-49.
[11] Ivi, pp. 50-51.
[12] Ivi, pp. 86-87.
[13] Ivi, pp. 88-89.
[14] Ivi, pp. 95-96.
[15] Ivi, pp. 107-108.
[16] Ivi, p. 122.
[17] Ivi, pp. 142-143.

(di Angelo Bisicchia)
Sono tante “le figlie” di Ibsen, ciascuna con un proprio carattere ben definito, conseguenza di storie passate e presenti. Non credo, però, che egli abbia espresso delle preferenze, benché le abbia dimostrate per Hedda, forse perché la più sfuggente e con caratteristiche più indeterminate rispetto alle altre. Anzi, è proprio l’indeterminatezza a farne un personaggio complesso.
Paolo Puppa, autore del saggio “La figlia di Ibsen – Lettura di Hedda Gabler”, edito da Cue Press, cita addirittura il “Principio di indeterminazione” di Heisenberg, come dire che non è possibile misurare le proprietà psicologiche di Hedda, poiché si abbandona ai suoi impulsi, alle sue nevrosi, sempre mutevoli. [continua a leggere su Lo Spettacoliere]
Silvia De Min, Decapitare Gorgone, Titivillus, 2016, € 16,00
(con un dialogo tra Paolo Puppa e la compagnia)
Vai alla scheda Libro Decapitare Gorgone
FINALLY, FORMS DEFINE THEMSELVES
BY THEIR ABSENCE,
THEIR FELT OMISSIONS.
(Iahb Hassan, The dismemberment of Orpheus,
Oxford, Oxford University Press 1982 p. 10)
Sull’orlo del boccascena
Autore eclettico, capace di misurarsi con canoni, linguaggi e ruoli sempre nuovi, Paolo Puppa ha costruito nel tempo un corpus di opere che appare oggi uno dei più fecondi della drammaturgia contemporanea. Proprio le caratteristiche che rendono il suo nome uno dei più suggestivi della cultura letteraria e teatrale dell’Italia nel nuovo millennio, ne rendono difficile una presentazione lineare, una presentazione che da considerazioni iniziali approdi ad una qualsiasi conclusione definitiva. Si tenterà, allora, di mettere a fuoco delle questioni che attraversano i suoi testi in maniera tale da fornire un primo strumento di lettura utile tanto all’analisi della parte critica della sua opera quanto di quella più strettamente drammaturgica.
Mito, malattia, monologo e voci che si intrecciano, creano la tessitura di una drammaturgia eterodossa, spesso capace di valutare se stessa convergendo su considerazioni che fanno parte dell’opera critica. Vice versa accade spesso che la pagina critica sia costruita come racconto consumabile, piéce da palcoscenico capace di rapire l’attenzione del lettore fino ad identificarsi con una delle pagine della sua drammaturgia. Proprio qui, in questo strano intreccio di possibilità e di specificità tra arte drammatica e critica, risiede la novità dell’opera di Paolo Puppa. Sintesi perfetta di questa intelaiatura di trame e orditi, è la figura del Performer Monologante, figura in bilico tra il teatro narcisistico del mattatore e il bisogno di riscoprire una parola nuova, che esprima il senso di una dolorosa consapevolezza del presente.
Sull’orlo del boccascena, c’è un uomo, solo, che guarda i frammenti della sua esistenza sparsi intorno, tentare di ricomporsi in un’unità impossibile. E’ l’uomo postmoderno: esitante, indeterminato, instabile e dispersivo, costruttore di realtà parallele che possiedono uno statuto di verità altrettanto reale. Il postmoderno, se non altro per ragioni anagrafiche, è canone e ipotesi interpretativa da cui partire per tentare di dare uno statuto alla drammaturgia di Paolo Puppa, costruita sulla crisi d’identità dei personaggi, sull’impossibilità di una comunicazione costruttiva, su un tempo irrigidito ad asettico presente, su uno spazio che non riesce ad essere davvero collocato da nessuna parte anche quando i luoghi vengono descritti nei minimi particolari e su un modello letterario che non è distintamente teatrale e neanche esattamente narrativo.
Per fare ordine all’interno di quel corpus che fino ad ora abbiamo considerato come unicum concettuale, riflettendo su temi, novità e particolarità, è necessario riconoscere al suo interno delle fasi di produzione. In corrispondenza con l’arrivo del nuovo millennio, esattamente nel 2000, Puppa scrive Famiglie di Notte, edito a Palermo dalla Sellerio, e nel 2002 è la volta di Venire, a Venezia (Milano, Bompiani): due opere il cui confine tra teatralità e narratività si snoda lungo una invisibile linea di demarcazione per cui accade che il genere di appartenenza oscilli e non vi sia la possibilità di dare alle pagine statuto definitivo. Il 2003 è, poi, l’anno di Angeli ed Acque. Cinque commedie veneziane (Corbo e Fiore, Venezia). Un’opera nella quale confluiscono cinque testi drammaturgici descritti dall’autore stesso come “commedie”, cinque ipotesi, all’apparenza testi dialogici, ma effettivamente lunghi monologhi di personaggi che non riescono, o non possono, comunicare tra loro.
Anche il 2004 si configura come anno proficuo per il teatro di Paolo Puppa: escono infatti proprio in questo anno Si, Famose (in ‹Passaggi>, 2) e Parole di Giuda (inedito). Il primo è un testo nelle forme si rifà a Famiglie di Notte proponendo una serie di monologhi recitati da donne famose, donne dell’arte, della storia e della leggenda, legati tra loro dalla circostanza forse più contingente di questo inizio di millennio: il crollo del World Trade Center per mano del terrorismo. Parole di Giuda, invece, è un testo più impegnativo, perfettamente inscrivibile nel movimento postmoderno, caratterizzato dal ribaltamento progressivo della morale occidentale e forse anche dalla sua decostruzione. Il monologo testamentario del protagonista, Giuda, appunto, ribaltando le categorie di giustizia divina e predestinazione ne riscatta la figura facendolo apparire come l’unico, vero martire della cristianità.