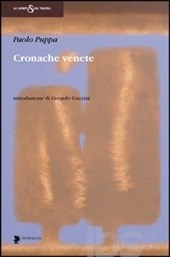Segnaliamo la recensione di Alfredo Sgroi a La recita interrotta. Pirandello: la trilogia del teatro nel teatro, Bulzoni Editore, Roma, uscita su Campi immaginabili. Si può leggere qui di seguito:
L’ultima fatica pirandelliana di Paolo Puppa, che allo scrittore siciliano ha dedicato nel corso degli anni numerosi saggi di capitale rilevanza, è anzitutto una suggestiva indagine sui meccanismi interni della produzione dello scrittore siciliano. Una nuova chicca critica confezionata per gli studiosi e i lettori dell’opera di Pirandello, ai quali lo stesso Puppa sa sempre riservare sorprese e proporre nuovi spunti ermeneutici. Diciamo subito che il titolo, così puntuale nel definire il recinto entro cui dovrebbe dipanarsi il discorso critico può trarre in inganno. Perché in questo agile e densissimo volume, non solo di teatro, e di teatro nel teatro, si discute. La classica trilogia metateatrale è infatti il perno centrale attorno al quale ruota la trattazione, e il filo rosso che ne lega i diversi momenti è «la recita interrotta» e abortita. Ma altro ribolle in queste pagine erudite e appassionate, frutto non solo di una lunga consuetudine con il mondo pirandelliano, ma di un vero e proprio atto d’amore che resiste al dileguare inesorabile del tempo.
La scena pirandelliana, argomenta Puppa, è certamente connotata dall’inquietante e quasi ossessivo ricorso all’interruzione, là dove il termine deve essere inteso nella sua accezione etimologica di «momento di frattura» (inter-rompo); di lacerazione improvvisa che spezza traumaticamente la linearità dell’intreccio e getta lo scompiglio tra gli ingranaggi della macchina teatrale. Lo studioso non si limita però a proporre questa cruciale chiave interpretativa: va ben oltre. Se si vuole, così tradisce felicemente l’intento esibito nel titolo per sprofondare, e far sprofondare il lettore, nell’abisso dell’immaginario e del vissuto dello scrittore siciliano, per cogliervi le ragioni profonde della fascinazione esercitata su Pirandello dalle spiazzanti lacerazioni della messa in scena; dalle fratture che sfrangiano personaggi e vicende; dalle conclusioni mancate (la vita non conclude, teorizzava il Don Cosmo Laurentano di I vecchi e i giovani) perché segmenti di vuoto interrompono, bloccando definitivamente, il decorso della realtà e della finzione. Da qui emerge l’immagine scivolosa di uno scrittore enigmatico e scomodo, che sulla scena trasla le sue (e le nostre?) ossessioni e i suoi insanabili conflitti interiori. Ora, perché tutto questo accade? Questa è la domanda da cui lo studioso parte per il suo personale viaggio à rebour nell’arte pirandelliana, riallacciandosi idealmente a quel lontano (e ormai classico) Fantasmi contro giganti apparso nel 1978, e pionieristicamente incentrato sul favoloso coronamento della trilogia metateatrale: su quei Giganti della montagna, cioè, che ormai in tanti considerano il capolavoro teatrale di Pirandello. Nel Prologo Puppa, ammiccando al lettore e reclamandone la disponibile complicità, avverte: «torno indietro a rileggermi le prime tre partiture», colorando con un tocco di nostalgia (sua e del lettore) questa nuova esplorazione della trilogia.
Si comincia, e non poteva essere altrimenti, con i Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 13-71), prima tappa della trilogia stessa che ha i foschi colori del lutto, come si segnala nella seconda parte del titolo: La famiglia che uccide. La morte, dunque, e la morte violenta maturata nell’inferno familiare è la prima (e non sola) componente che caratterizza per lo studioso il plot di quest’opera teatrale. Con una sorta di racconto critico, condotto sul filo della narrazione, Puppa ne ricostruisce con il piglio dell’affabulatore di razza l’itinerario scenico e compositivo, a partire dal clamoroso insuccesso romano del 1921, che certo non lasciava presagire nulla buono. Salvo poi rivelarsi Un fortunato fallimento (pp. 13-15), per dirla con una formula ossimorica ed efficacissima che lo studioso conia per segnalare un dato storico fondamentale: la tempestosa messa in scena romana, sfociata in una caduta apparentemente senza appello, innesca paradossalmente la marcia trionfale dei Sei personaggi, destinati a diventare non solo la piéce più celebre tra quelle composte da Pirandello, in virtù anche delle revisioni successive sollecitate dall’esito contrastato della «Prima», ma un autentico concentrato degli ingredienti tipici del suo teatro e il detonatore di una rivoluzione teatrale. Ecco dunque, nella descrizione iniziale di Puppa, la scena vuota in cui cominciano a sfilare i componenti della Compagnia che deve mettere in scena Il giuoco delle parti. Qui, come per magia, irrompe «una famiglia allargata e squinternata», coinvolta in una fosca tragedia in cui si assembra «un cumulo insolito di atrocità»: dall’incesto sfiorato alla morte violenta di due fanciulli, passando per la prostituzione della Figliastra. Tutto ciò è avvenuto, eppure, su richiesta del Padre e della stessa Figliastra, tutto deve ripetersi sulla scena. Il progetto, come è noto, fallisce perché non soltanto l’Autore ha rigettato le pretese dei suoi personaggi, ma anche perché la macchina scenica tradizionale si rivela inadeguata a rappresentare il dramma. Eppure, sottolinea Puppa, lo scacco reiterato e la sua messa in scena si rivela insolitamente fecondo: «mai un fallimento è risultato tanto produttivo per il drammaturgo» (p. 14). Mai un concepimento abortito, si può aggiungere, è stato così lucroso per l’autore che, nel complesso gioco della finzione, si è rifiutato di «partorire» i personaggi che pure sono stati in gestazione nella sua fantasia creativa. Se la loro origine resta avvolta nelle nebbie del mistero, pure è chiaro che la loro irruzione in scena obbedisce ad un preciso impulso dell’autore che, non a caso, scrivendo dell’opera dichiara di essersi così liberato da un incubo. Partendo da questa vera e propria confessione Puppa punta il suo sguardo indagatore sulle ragioni di questo stesso «incubo»; ne rintraccia scorie e sedimenti in diversi testi precedenti e nella tormentata biografia dell’autore. Qui urge infatti il meduseo desiderio incestuoso, affascinante e repellente; qui scalpita una Fantasia (quella dell’Autore) «vestita sempre a lutto» (p. 19), sempre tesa a disgregare e corrodere, e a frequentare i territori eccentrici della condizione patologica. L’opera diventa perciò un farmaco omeopatico per lo stesso Pirandello, e nel momento stesso in cui imbastisce una galleria di personaggi spiazzanti, devianti e tarati. Così, la Figliastra è l’ennesima epifania della ragazza corrotta «da maschi assatanati», imparentata con le fanciulle inquietanti di Come prima meglio di prima e di Vestire gli ignudi (p. 29). L’eros, dunque, travolge e talvolta uccide. Nei Sei personaggi come altrove. Lo conferma, nella sua fisionomia mutante nel passaggio da una redazione all’altra, il Padre, principale indiziato del crimine familiare e, soprattutto, ennesima rappresentazione del «prototipo del borghese animalesco dentro e filisteo fuori» (p. 33), anch’egli simile ad altri personaggi pirandelliani.
Di notevole suggestione e spessore è anche la puntigliosa analisi della fenomenologia della psiche femminile che Puppa svolge, ancora una volta, comparando materiale novellistico e teatrale, mettendo così in rilievo come spesso lo scrittore presenta figure femminili instabili e volubili, nervosamente cangianti, proprio come è il caso della Figliastra. In ciò degna espressione di una realtà, quella familiare, che ha le stimmate demoniache del male, riducendosi ad una sfera relazionale forzata, entro la quale «si muore e si uccide», entro uno spazio claustrofobico e sinistramente fagocitante, in cui si dibattono e spesso soccombono i personaggi pirandelliani, poiché «tutte le creature nell’opera pirandelliana […] sono prigioniere del carcere familiare, spinte ad un reciproco cannibalismo» (p. 41). Puppa propone a questo proposito un intrigante paragone con Stefano Giogli uno e due, a confermare un approccio comparativo e problematico.
Non vi è dubbio comunque, aggiunge lo studioso, che nei Sei personaggi si susseguono a ritmo vorticoso dei veri e propri cortocircuiti: quello tra attori e personaggi, in primis, con le schermaglie che attestano un esplicito «scontro tra i due mondi» (p. 46); poi quello tra il Capocomico dalla labile identità, sospeso com’è tra capocomicato tradizionale e nuova condizione registica, e i Personaggi, che col Padre ad un certo punto riescono ad adescarlo e a persuaderlo a farsi addirittura «autore». E c’è poi, ad alimentare la conflittualità sulla scena, lo sfarinamento della figura d’autorità per eccellenza: proprio quel «Padre detronizzato» (pp. 53-58) che condivide il destino di altre simili creature di Pirandello. Il che, considerata l’eclissi del principio di autorità, rende impossibile una soluzione ordinata e lascia libero il campo al trionfo del caos. Così, conclude Puppa, accade che la tragedia abortisce e la soluzione catartica tentata sul palcoscenico si risolve in uno scacco cocente, poiché la parola, che avrebbe dovuto essere un balsamo terapeutico e sanare le ferite aperte, al contrario le acuisce. Si verifica, insomma, una cupa eterogenesi dei fini o, se si vuole, un compiaciuto e dissacrante sovvertimento di tutti i canoni: scenici, tematici, perfino etici. A chiudere questa prima sezione del saggio (come per le successive) è una preziosa Nota al testo (pp. 64-71), corredata da una succinta ma raffinata bibliografia.
Ciascuno a suo modo è il secondo momento della «trilogia». Anche in questo caso non mancano nell’intervento di Puppa notazioni sorprendenti e acute, nonché comparazioni stimolanti con altre opere pirandelliane, e non solo. Segnaliamo qui il parallelismo tra il raisonneur Diego Cinci e Serafino Gubbio, protagonista dell’omonimo romanzo; o, ancora le interferenze con Il giuoco delle parti (p. 79) e il Così è (se vi pare), con una collaterale puntata sul teatro di Brecht e sull’opera di Weininger. Elementi innovatori, chiarisce Puppa, connotano la struttura della piéce. Pirandello si esibisce infatti in un arduo gioco combinatorio sperimentale, compiacendo la sua pervicace voluttà di provocazione, veicolata in questo caso contro il pubblico bigotto e i critici astiosi, anche per avere una sorta di rivalsa personale. Tutti ingredienti, questi, che spingono Puppa a suggerire altre interferenze: con il Futurismo, ad esempio, o con il laboratorio di Joyce. Tenendo fermo che «tutta la pagina narrativa pirandelliana mostra un’esplosiva vocazione all’oralità e all’opzione monologante», perciò giocoforza contigua con i codici espressivi del teatro, nell’ambito di una insopprimibile e maniacale coazione a ripetere, puntualmente segnalata dallo studioso e individuata come una cifra interpretativa essenziale per cogliere le caratteristiche peculiari della commedia: «Ciascuno a suo modo declina con energie ora rinnovate ora logore le priorità dell’universo pirandelliano» (p.105); un universo che concentra in sé i vari generi saggiati dallo scrittore siciliano. Il che si coglie anche nel terzo momento della trilogia, in cui la frammentazione, il caos, le conflittualità irrisolte, sfociano per lo studioso in una «Disarmonia prestabilita» che, provocatoriamente, scivola in un «eccesso del metateatro», incerto ma plausibile. Puppa conduce quindi per mano il lettore in quell’autentico labirinto che è Questa sera si recita a soggetto, evidenziando la presenza delle consuete «vite tribolate e luttuose» (p. 137); degli eccessi e degli squilibri che minano dalle fondamenta il traballante istituto familiare. Sul palcoscenico si consuma l’ennesimo blocco, che neppure l’aspirante demiurgo-regista, pomposamente orgoglioso di accentrare in sé la direzione della macchina scenica, svilendo il ruolo dell’autore anzitutto, e degli interpreti poi, riesce a risolvere. Alla fine l’ingorgo drammatico, se possibile, si addensa ancora di più, scatenando la reazione di attori e pubblico, in una bagarre che sancisce il sinistro trionfo della «tensione alla decomposizione».
Miscelando dunque la componente informativa con quella analitica, in una sintesi nella quale si addensa l’immaginario e la teoresi pirandelliana Puppa, anche in questo saggio, traccia un quadro di ampio respiro nel quale la scena, la scrittura, le manie esistenziali e le opzioni estetiche e filosofiche si incrociano per intrecciare una fitta trama di interferenze. Merito di Puppa, tra l’altro, è anche quello di non avere isolato l’oggetto della sua indagine, immergendolo nel ribollente calderone dell’arte pirandelliana, mantenendone aperti i canali osmotici.
ALFREDO SGROI